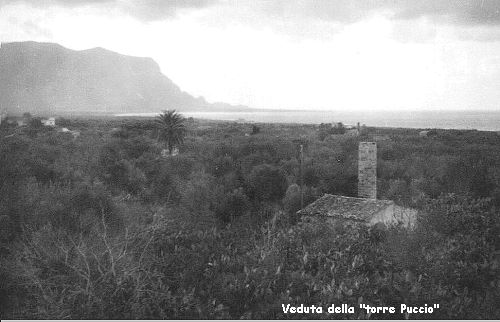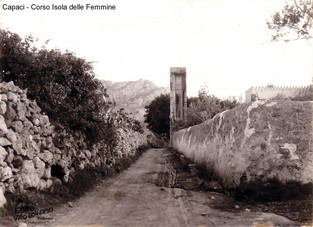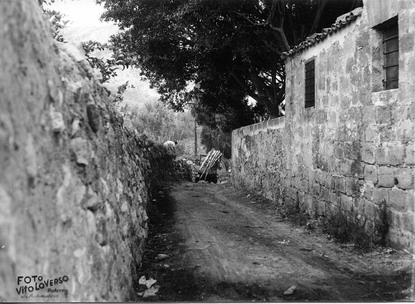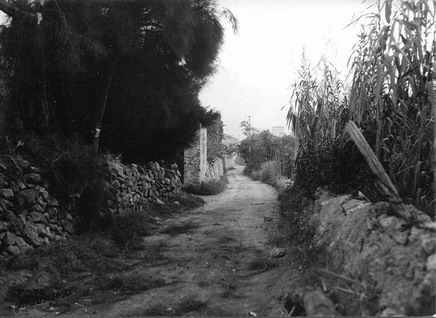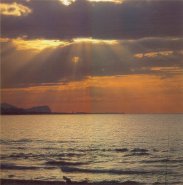Il
territorio
Le risorse economiche
Il territorio non è molto
ricco di terreni pianeggianti coltivabili. Le sole aree con interramento
sufficiente allo sviluppo agricolo e privo di rocce affioranti sono concentrate
nella pianura a sud del centro abitato ed individuano le Contrade
Carrubella e
Sommariva. Ad esse si aggiungono piccoli appezzamenti nella valle del torrente
Ciachea che vanno sotto il nome di
Contrada Luogo Grande.
In queste zone un razionale
sfruttamento delle risorse idriche disponibili (costituite in
gran parte da pozzi artesiani e da qualche sorgente nelle zone montuose meridionali)
e una capillare rete di tubazioni sotterranee in terracotta avevano permesso
comunque lo sviluppo di splendidi giardini, coltivati principalmente ad ulivi ed
agrumi, fiorenti fino alla metà del secolo XIX.
parte da pozzi artesiani e da qualche sorgente nelle zone montuose meridionali)
e una capillare rete di tubazioni sotterranee in terracotta avevano permesso
comunque lo sviluppo di splendidi giardini, coltivati principalmente ad ulivi ed
agrumi, fiorenti fino alla metà del secolo XIX.
Verso
la fine dello stesso secolo una stazione di pompaggio, ubicata in Contrada Pozzo
e nota con il nome di
"Macchina Oliveri", divenne la principale fonte di irrigazione
dei terreni agricoli posti anche fino a 70 mt. sul livello del mare attraverso
una fitta rete di distribuzione che riusciva a soddisfare il fabbisogno di quasi
tutto il territorio comunale. L'acqua veniva sollevata a mezzo di una pompa
sommersa alimentata da una macchina a carbone da un pozzo profondo circa otto metri fino alla
cima di un'alta torre, costruita in mattoni rossi e visibile a grande distanza, da dove, sfruttando un ben noto principio fisico, veniva
fatta defluire fino ad una colonna posta a quota più elevata ma ad uguale
altezza della prima e nota come "Torre Puccio" e da quì, secondo lo stesso
principio ed a mezzo di altri castelletti, inviata ancora più lontano, fino alla sua
destinazione.
Il funzionamento della macchina,
di
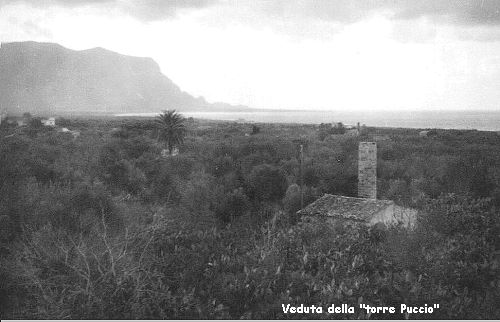 costruzione austriaca, non conobbe soste tranne che nel corso della seconda
guerra mondiale nei periodi in cui il carbone venne a mancare per cui soltanto
chi aveva la possibilità di fornirlo personalmente potè fruire del servizio.
costruzione austriaca, non conobbe soste tranne che nel corso della seconda
guerra mondiale nei periodi in cui il carbone venne a mancare per cui soltanto
chi aveva la possibilità di fornirlo personalmente potè fruire del servizio.
Agli inizi degli anni '50, in piena era industriale, l'alimentazione a carbone
veniva sostituita con quella ad energia elettrica. Ma già l'agricoltura mostrava
i segni di un progressivo cedimento produttivo i cui effetti hanno determinato
una lenta ma irreversibile tendenza alla cessazione definitiva dell'attività
della "Macchina Oliveri", avvenuta alla fine degli anni '80.
L'espansione
urbanistica e la frammentazione delle proprietà terriere nel volgere di pochi
anni hanno fatto il resto portando, purtroppo, alla distruzione della rete
d'irrigazione e all'abbandono delle coltivazioni.
Le zone rocciose sono
invece rimaste occupate da macchie mediterranee nelle quali sopravvivono pochi
esemplari di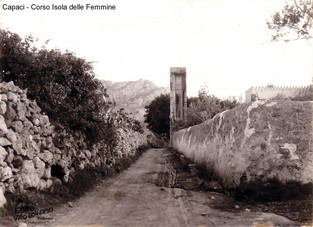 carrubo e di frassino da manna la cui estrazione costituì per lungo
tempo una
delle principali risorse economiche locali e la cui qualità molto pregiata valse
a dare al paese una particolare rinomanza anche oltre i confini territoriali.
carrubo e di frassino da manna la cui estrazione costituì per lungo
tempo una
delle principali risorse economiche locali e la cui qualità molto pregiata valse
a dare al paese una particolare rinomanza anche oltre i confini territoriali.
Paese
metà agricolo e metà marinaro, Capaci è stata sempre una delle comunità più
ragguardevoli delle contrade occidentali di Palermo, quasi pioniera di progresso
civico per la laboriosità dei suoi abitanti dalla personalità versatile
formatasi per strati sociali al passo con i tempi e tempratasi per molti nella
solitudine di terre lontane alla ricerca di un destino migliore.
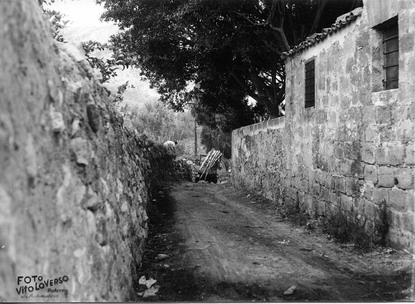
Nel
secolo scorso, quando ancora costituiva un unico ceppo con Isola delle Femmine,
vantava grandi tradizioni marinare e rappresentava una scuola artigianale di
tutto riguardo: era l'epoca in cui abili maestri d'ascia (falegnami) costruivano
quelle barche ampie e leggere, armoniche e salde nella linea, chiamate, appunto,
‘capaciote', le quali, tra la fine dell'800 e i primi decenni del '900,
solcarono sicure i mari aperti spingendosi da sole od in formazione con altri
pescherecci fin sulle coste della Tunisia e dell'Algeria.
Ma anche
le sue tradizioni agricole sono rimaste legate ad una specifica cultura tipica
di questo territorio:
quella
del fico d'India che cresceva un po'
dovunque; non solo sulle pendici dei monti ma anche vicinissimo al mare,
bastando poca terra alla sua sopravvivenza. E non era raro vedere delle piante
di fico d'India crescere nella sabbia, vicinissime alla
battigia. Eppure pochi sanno che il fico d'India ha trovato la piena
valorizzazione dei suoi frutti proprio a Capaci ove pare abbia avuto origine la
ben nota operazione della 'scuzzulatura', ovvero il taglio delle prime gemme che
permette di ottenere frutti più grossi e più saporiti.
Sull'origine della 'scuzzulata', che deriva da una tecnica colturale
solitamente impiegata alla fine della primavera, consistente nell'eliminazione
di buona parte dei fiori e dei frutticini ad essi congiunti, lo scrittore
palermitano Giuseppe Pitrè (1841 - 1916) riferisce:

"...E'
voce generale che un colono di Capaci si rifiutasse di vendere la produzione dei suoi fichi d'India ad un conterraneo che vi aspirava, e che costui, indignato
del diniego, vendicasse la ricusa con la violenza, atterrandogli i frutti in
piena fioritura. Questo eccesso vandalico produsse effetti contrari alle
sinistre intenzioni del malvagio autore. I frutti rinacquero poco dopo sugli
internodi in minor numero, ma turgidi e promettenti oltre l'usato, e vennero a
maturare con buccia fine e polpa così serrata e consistente da potersi
conservare in magazzino per più mesi all'anno e resistere agli eventi delle
lunghe navigazioni...". Veniva in tal modo assicurata quella commercializzazione
del prodotto sui mercati esteri che avrebbe trovato largo sviluppo ai nostri
giorni.
dei suoi fichi d'India ad un conterraneo che vi aspirava, e che costui, indignato
del diniego, vendicasse la ricusa con la violenza, atterrandogli i frutti in
piena fioritura. Questo eccesso vandalico produsse effetti contrari alle
sinistre intenzioni del malvagio autore. I frutti rinacquero poco dopo sugli
internodi in minor numero, ma turgidi e promettenti oltre l'usato, e vennero a
maturare con buccia fine e polpa così serrata e consistente da potersi
conservare in magazzino per più mesi all'anno e resistere agli eventi delle
lunghe navigazioni...". Veniva in tal modo assicurata quella commercializzazione
del prodotto sui mercati esteri che avrebbe trovato largo sviluppo ai nostri
giorni.
Fin
dall'età storica i boschi di frassino hanno coperto le valli e le pendici dei
monti di questo territorio che certamente Cartaginesi e Romani dovettero
visitare frequentemente perché il legno di frassino, a quei tempi, trovava
larghissimo impiego anche nella produzione di aste per le lance che, come è
noto, costituivano le tradizionali armi di assalto e di sfondamento impiegate
dalle due milizie nelle battaglie.
La
cultura del frassino cedette poi all'impianto dei primi giardini e Capaci,
fino alla prima metà del secolo scorso, si trovò circondata da fiorenti
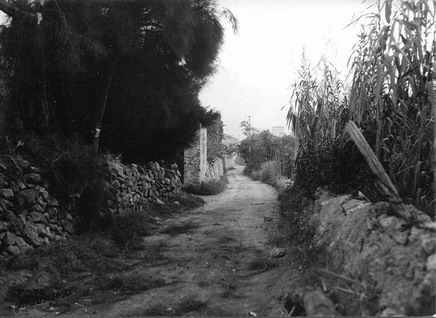 agrumeti
che occupavano quasi tutte le aree irrigue coltivabili e, particolarità
singolare, furono impiantati anche all'interno di antiche cave di pietra
abbandonate, buone a difendere limoni ed aranci dal vento e dalla salsedine.
agrumeti
che occupavano quasi tutte le aree irrigue coltivabili e, particolarità
singolare, furono impiantati anche all'interno di antiche cave di pietra
abbandonate, buone a difendere limoni ed aranci dal vento e dalla salsedine.

Peccato
che di questa lussureggiante vita ipogea degli agrumi non sia rimasta quasi più
traccia essendo state convertite quelle vecchie cave in aree edificatorie per
villette più o meno abusive.
Erano
tempi (poi non tanto lontani) di un paesaggio sereno e ancora arcadico con
mandrie di pecore e mucche che pascolavano lungo i pendii delle coste e negli
avvallamenti di Soprabanco avendo per stalle le fresche profondità delle grotte
tufacee.
La fascia
pedemontana dei monti Raffo Rosso e Muletta era ancora intatta, fitta di
frassini e oleastri, residui della folta macchia che già diversi secoli prima
aveva caratterizzato il territorio insieme a fichi d'India, pistacchi, olivi, carrubi,
alle alte ferule e alle superbe agavi un tempo così fitte e così somiglianti,
nelle loro altissime efflorescenze, ad un esercito di orgogliosi lancieri in
marcia.
Poi,
superata la soglia degli anni '50, le condizioni ambientali sono radicalmente
mutate con l'avvento della
speculazione edilizia e dell'incontrollato abusivismo, dilagati a macchia d'olio
nel territorio, reso anonimo e cementificato.
Quanto ai capacioti, essi, adeguandosi alle veloci
trasformazioni dei tempi, oggi prestano la loro opera nelle attività
terziarie e
 turistiche; sono imprenditori e commercianti e, come in passato,
molti di loro continuano a percorrere le vie del mondo dove li porta lo spirito
di laboriosità e di intraprendenza.
turistiche; sono imprenditori e commercianti e, come in passato,
molti di loro continuano a percorrere le vie del mondo dove li porta lo spirito
di laboriosità e di intraprendenza.
Quanto allo sviluppo
industriale, negli anni '60 si è assistito all'insediarsi di due complessi
industriali di medie dimensioni: la SINES per la produzione di vermouth e la VIANINI per la costruzione di pali in cemento.
Dei
due stabilimenti, appartenenti a grandi imprese multinazionali, posti alle
estremità est ed ovest del paese in stretta connessione con la viabilità
stradale e ferroviaria: il primo (SINES) è stato trasformato in industria
casearia per la produzione di mozzarella ed in centro commerciale alimentare;
il secondo (VIANINI) è attualmente in corso di smantellamento e non è logico
pensare che possa in qualche modo riprendere il ciclo produttivo.
Altra attività, d'interesse
artigianale, era costituita dall'industria estrattiva della pietra ricavata dai
pendii di Pizzo Muletta e dalla fabbrica di calcestruzzo operante in loco.
Gran parte dell'economia del
paese dipende ancora oggi dal commercio di tessuti esercitato soprattutto in
forma ambulante. Ma non è utopistico pensare che un'attività artigianale a
carattere turistico, flessibile e moderna, non possa far nascere un polo di interesse
economico alternativo. Si pensi, per esempio, alla lavorazione del legno, della
plastica o della ceramica per la produzione di oggetti artistici, arricchiti
magari da ornamenti e decorazioni fantasiosi, a colori nuovi e accattivanti, che
certamente l'inventiva della nuova generazione locale non mancherebbe di
valorizzare. 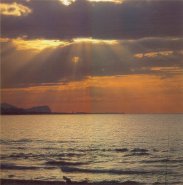
A questa si aggiunge una
piccola attività stagionale, legata alla fruizione della spiaggia, che risulta
scarsamente incisiva per l'assenza di infrastrutture di base
indispensabili per imprimere una svolta decisiva al decollo di un turismo veramente attivo da
permettere ai visitatori una permanenza più lunga e confortevole con un notevole
incremento dell'economia locale.
Le premesse per un sicuro sviluppo ci sono tutte: il clima,
caratterizzato da inverni miti e umidi e da estati calde, secche e molto lunghe;
il cielo quasi sempre limpido e terso; il fascino di panorami senza confini ed
una cittadina pulita e laboriosa, non molto rumorosa nè caotica, dove è ancora
possibile ascoltare il canto mattutino degli uccelli od il frinire incessante
delle cicale negli assolati meriggi estivi.
 parte da pozzi artesiani e da qualche sorgente nelle zone montuose meridionali)
e una capillare rete di tubazioni sotterranee in terracotta avevano permesso
comunque lo sviluppo di splendidi giardini, coltivati principalmente ad ulivi ed
agrumi, fiorenti fino alla metà del secolo XIX.
parte da pozzi artesiani e da qualche sorgente nelle zone montuose meridionali)
e una capillare rete di tubazioni sotterranee in terracotta avevano permesso
comunque lo sviluppo di splendidi giardini, coltivati principalmente ad ulivi ed
agrumi, fiorenti fino alla metà del secolo XIX.